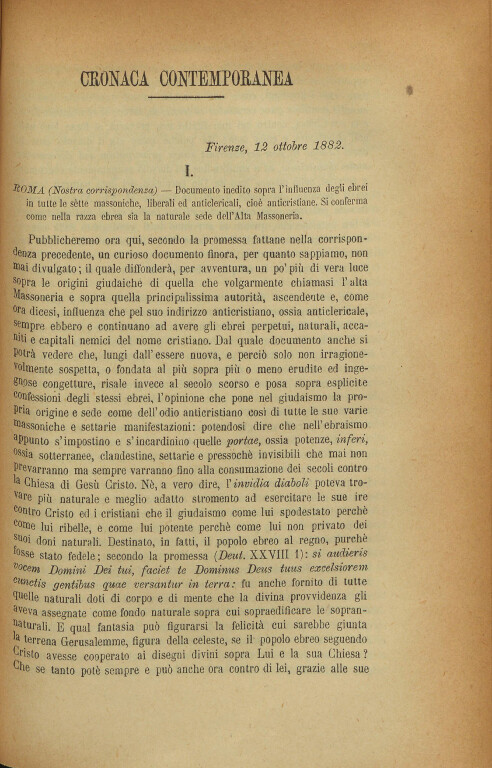
Album "Il cimitero di Praga"
In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del romanzo Il cimitero di Praga di Umberto Eco (2010), che fanno riferimento agli eventi e ai temi trattati nell’opera o che possono avere fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione del testo letterario (quando abbiamo presentato un’interpretazione critica è perché altri l’avevano già proposta e ci sembrava utile discuterne). Ancor meno si vuole dare un giudizio sui tanti temi complicati e scomodi presenti nel romanzo, che meritano approfondimenti ben più avanzati.
Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie) che non vuole essere esaustivo di tutte le opere citate nel romanzo. Anzi anche l’assenza dalla gallery di alcuni testi citati da Eco, dovuta spesso al fatto che quella specifica opera non è conservata in biblioteca, può avere un significato per opere che spesso hanno avuto una vita controversa, trattato temi spinosi e viaggiato sul confine fra falso, plagio, provocazione e inganno.
Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 2010.
I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.
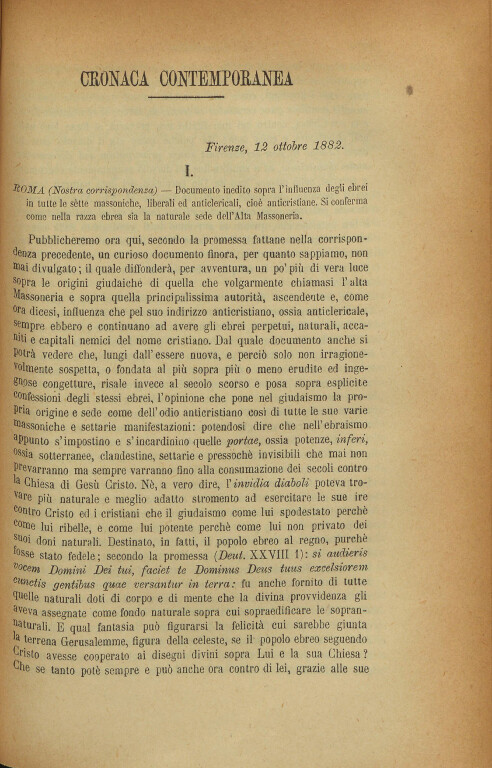
Lettera di Giovanni Battista Simonini a Barruel
Il passo decisivo per scrivere il «“romanzo dei Protocolli”» è la creazione di un protagonista che possa tenere in mano i fili della narrazione attraversando più di mezzo secolo di storia europea rimanendo nell’ombra. Il prototipo di quel personaggio esiste già. Anzi, forse non è mai esistito ma spesso si è dato credito alla sua esistenza. È il capitano Giovanni Battista Simonini. In un romanzo è perfettamente lecito assumere come reale la sua figura, costruirgli intorno un ambiente e una famiglia e utilizzare un suo discendente, il nipote Simone Simonini (sicuramente personaggio fittizio ma, lo abbiamo visto, anche incerto sulla propria identità), come protagonista e erede dell’odio antiebraico del nonno.
Ma chi era Giovanni Battista Simonini, o meglio l’entità autoriale che venne chiamata Giovanni Battista Simonini? Lasciamo la parola all’Eco saggista, che rivela quello che lo stesso Simone racconta nel romanzo ricostruendo la proria infanzia nel quarto capitolo, I tempi del nonno:
«Il libro di Barruel non conteneva alcun riferimento agli ebrei. Ma nel 1806 Barruel ricevette una lettera da un certo capitano Simonini che gli ricordava come Mani e il Veglio della Montagna (notoriamente alleati dei Templari originali) fossero ebrei anch’essi, che la massoneria era stata fondata da ebrei, e che gli ebrei si erano infiltrati in tutte le società segrete. Sembra che la lettera di Simonini fosse stata forgiata da agenti di Fouché [capo della polizia politica francese, n.d.r.], il quale era preoccupato dei contatti di Napoleone con la comunità ebraica francese.
Barruel fu preoccupato dalle rivelazioni di Simonini e pare avesse affermato privatamente che a pubblicarla si sarebbe corso il rischio di un massacro. Di fatto egli scrisse un testo dove accettava l’idea di Simonini, poi lo distrusse, ma la voce si era ormai diffusa. Questa voce non produsse effetti interessanti sino alla metà del secolo, quando i Gesuiti iniziarono a preoccuparsi degli ispiratori anticlericali del Risorgimento, come Garibaldi, che erano affiliati alla massoneria. L’idea di mostrare che i Carbonari erano gli emissari di un complotto giudeo-massonico appariva polemicamente fruttuosa».
(Umberto Eco, Sei passeggiate nei boschi narrativi, p. 166-167).
Idea fruttuosa anche sul piano narrativo, visto che in queste poche righe vediamo davvero il riassunto di buona parte del romanzo pubblicato circa 15 anni dopo.
La lettera di Simonini viene riscoperta in più occasioni. Qui vediamo la prima pagina della prima traduzione italiana, pubblicata sul periodico «La civiltà cattolica» nell’ottobre 1882. Qui è possibile leggere integralmente questa prima traduzione.
Documento inedito sopra l’influenza degli ebrei in tutte le sètte massoniche, liberali ed anticlericali, cioè anticristiane. Si conferma come nella razza ebrea sia la naturale sede dell’Alta Massoneria, «La civiltà cattolica», XXXIII, 1882, vol. 12, p. 219-228.
