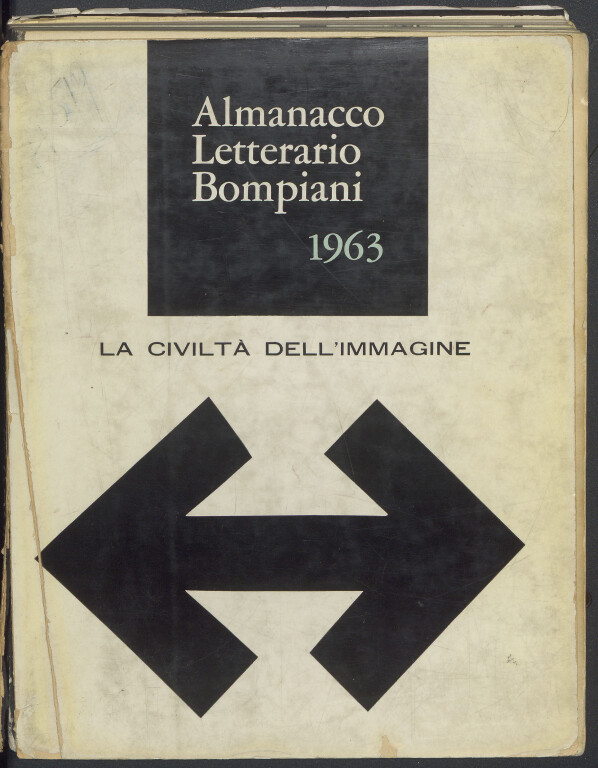
Album "Apocalittici e integrati"
In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del saggio Apocalittici e integrati di Umberto Eco (1964), che fanno riferimento ai temi trattati nell’opera o hanno fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione critica del lavoro di Eco.
Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie). Non solo non c’è pretesa di esaustività, poniamo anzi una dichiarazione preventiva del fatto che maggiore attenzione si è data alla parte relativa ai fumetti, considerata più interessante e adatta al percorso di lettura del nostro gruppo, mentre canzone e TV sono trattate qui in maniera episodica. Non si fanno inoltre quasi riferimenti ai capitoli Cultura di massa e “livelli” di cultura e La struttura del cattivo gusto, che naturalmente sono però la base teorica implicata nella presentazione dei documenti da noi preparata come del lavoro di analisi dei testi - grafici, testuali e sonori - fatta dall’autore.
Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 1964.
I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.
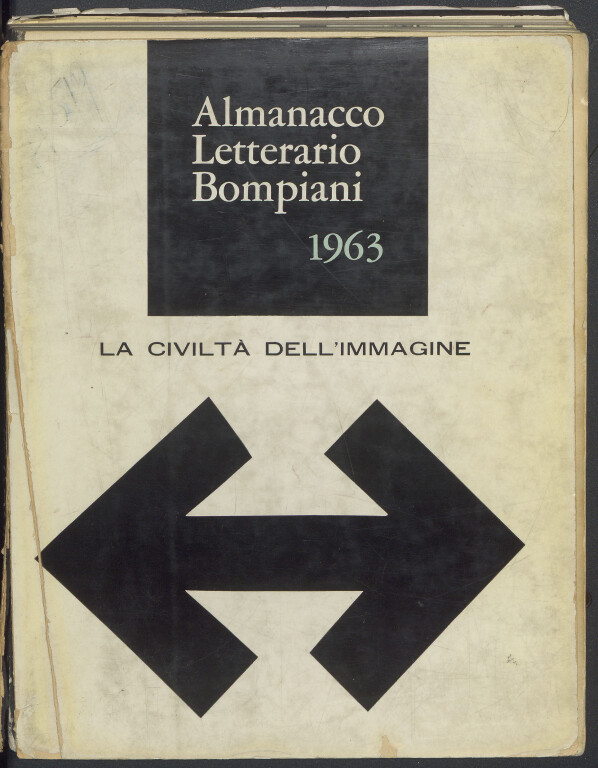
Almanacco Letterario Bompiani. La civiltà dell'immagine (1963)
Stefano Traini in Le avventure intellettuali di Umberto Eco ricorda che la nascita di Apocalittici e integrati fu casuale, trattandosi di «saggi eterogenei, raccolti in volume per partecipare a un concorso per una cattedra universitaria sulle comunicaizoni di massa». Ma aggiunge che la genesi del libro «è casuale solo dal punto di vista personale [...] mentre dal punto di vista culturale l’interesse per i media all’interno della cultura di massa in quel periodo era palpabile». Stesso concetto affermato da Fausto Colombo in Il SuperEco. Umberto Eco, Supermann e i media studies, in 50 anni dopo Apocalittici e integrati di Umberto Eco, p. 45-51: 46.
In questo interesse crescente rientra inevitabilmente un’attenzione più specifica verso l’uso delle immagini in questi prodotti culturali, come dimostra il numero del 1963 dell’«Almanacco Letterario Bompiani», più volte citato da Eco e intitolato proprio La civiltà dell’immagine. Ricordando che con Bompiani Eco collaborava in numerosi progetti editoriali, se si guarda l’indice di questo volume si nota che molti degli argomenti elencati coincidono con quelli presenti in Apocalittici e integrati.
Eco sottolinea in più occasioni come in realtà le immagini siano state veicolo culturale fondamentale in moltissime società del passato e che quindi oggi abbiamo una civiltà dell’immagine come ce ne sono state altre, ognuna con caratteristiche proprie. L’aspetto più importante è cogliere l’essenza comune alla modalità di diffusione culturale tramite l’immagine:
«Ma il linguaggio dell’immagine è sempre stato lo strumento di società paternalistiche che sottraevano ai propri diretti [sic] il privilegio di un corpo a corpo lucido col significato comunicato, libero dalla presenza suggestiva di una “icone” concreta, comoda e persuasiva. E dietro ad ogni regìa del linguaggio per immagini c’è sempre stata una élite di strateghi della cultura educati sul simbolo scritto e sulla nozione astratta. Una civiltà democratica si salverà solo se farà del linguaggio dell’immagine una provocazione alla riflessione critica, non un invito all’ipnosi» (p. 347-348).
E ancora:
Ricordiamo che una educazione attraverso le immagini è stata tipica di ogni società assolutistica e paternalistica; dall’antico Egitto al Medioevo. L’immagine è il riassunto visibile e indiscutibile di una serie di conclusioni a cui si è giunti attraverso l’elaborazione culturale; e l’elaborazione culturale che si avvale della parola trasmessa per iscritto è appannaggio dell’élite dirigente, mentre l’immagine finale è costruita per la massa soggetta. In questo senso hanno ragione i manichei: c’è nella comunicazione per l’immagine qualcosa di radicalmente limitativo, di insuperabilmente reazionario. E tuttavia non si può rifiutare la ricchezza di impressioni e di scoperte che in tutta la storia della civiltà i discorsi per immagini hanno dato agli uomini.
Una saggia politica culturale [...] sarà quella di educare, magari attraverso la TV, i cittadini del mondo futuro a saper contemperare la ricezione di immagini con una altrettanto ricca ricezione di informazioni “scritte” (p. 358).
Il linguaggio del fumetto, di cui Eco analizza le strutture fondamentali subito dopo la lettura della prima tavola pubblicata dello Steve Canyon di Milton Caniff, si fonda proprio sulla dialettica e il dialogo fra testo e immagine.
La civiltà dell’immagine, «Almanacco Letterario Bompiani», 1963.
