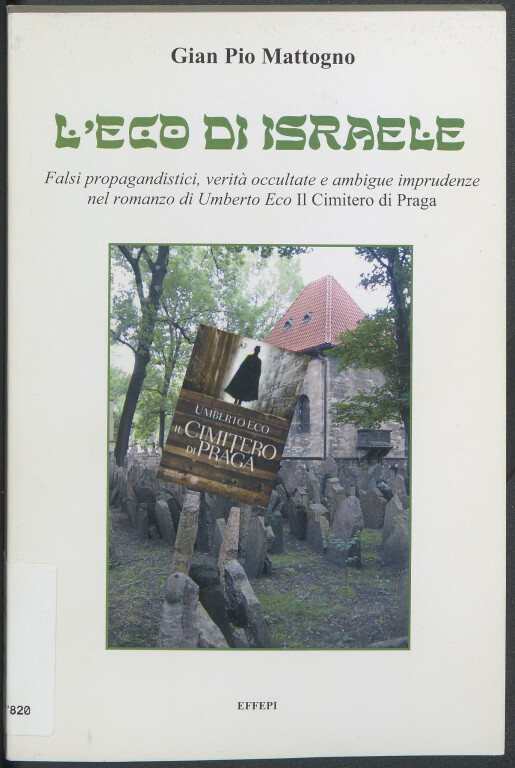
Album "Il cimitero di Praga"
In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del romanzo Il cimitero di Praga di Umberto Eco (2010), che fanno riferimento agli eventi e ai temi trattati nell’opera o che possono avere fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione del testo letterario (quando abbiamo presentato un’interpretazione critica è perché altri l’avevano già proposta e ci sembrava utile discuterne). Ancor meno si vuole dare un giudizio sui tanti temi complicati e scomodi presenti nel romanzo, che meritano approfondimenti ben più avanzati.
Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie) che non vuole essere esaustivo di tutte le opere citate nel romanzo. Anzi anche l’assenza dalla gallery di alcuni testi citati da Eco, dovuta spesso al fatto che quella specifica opera non è conservata in biblioteca, può avere un significato per opere che spesso hanno avuto una vita controversa, trattato temi spinosi e viaggiato sul confine fra falso, plagio, provocazione e inganno.
Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 2010.
I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.
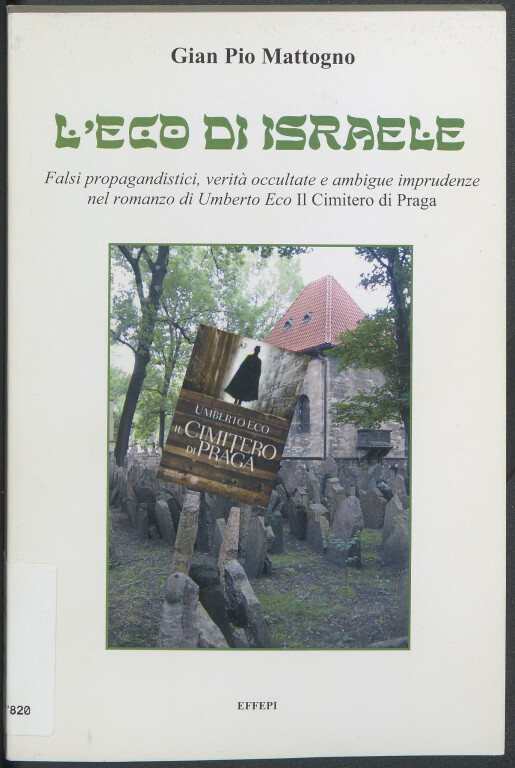
Gian Pio Mattogno, L'Eco di Israele (2013)
La pubblicazione di un romanzo di Eco generava sempre grande curiosità e conseguente proliferare di recensioni. Non andremo a riprenderle, limitandoci a poche citazioni per porre in tavola una questione importante perché base costitutiva del romanzo stesso.
Il tema di nostro interesse non è la “questione ebraica”, che naturalmente divenne l’argomento principale di discussione intorno al romanzo, ma quello che potremmo definire il grado di verità e verificabilità delle vicende narrate.
Il volumetto di cui vediamo la copertina ha un unico merito, quello di offrire una panoramica piuttosto ampia delle recensioni uscite all’indomani della pubblicazione. Per il resto è un perfetto esempio del modo sbagliato di leggere un romanzo e ancora più questo romanzo:
«Al pari di altri storici suoi sodali, lo smascheratore si adopera a dissimulare la vera natura e i veri fini del giudaismo internazionale, ma con l’aggravante che allo storico non è consentita la mancanza di rigore scientifico, mentre al romanziere Eco, con la scusa della licenza poetica e della tecnica narrativa della riscrittura, è perdonata ogni concessione alla caricatura, alla incongruenza, alla inverosimiglianza, al falso storico e al plagio».
Gian Pio Mattogno, L'eco di Israele, p. 9.
Proprio il gioco della riscrittura, del celare le fonti utilizzandole nella narrazione senza dichiararle, di dare per veri documenti falsi, è il tema fondamentale del romanzo, che Eco trasferisce sapientemente - pur se talvolta in maniera quasi esagerata, tanto da rendere meno piacevole il semplice godimento della storia narrata - dal piano del contenuto a quello della forma. Fra i saggi che Eco dedica alla questione vanno ricordati almeno Falsi e contraffazioni, in I limiti dell’interpretazione (p. 162-192) e La forza del falso, in Sulla letteratura (p. 309-341).
Il falsario Denis Vrain-Lucas, «uomo di genio» (p. 16) le cui imprese sono ricordate da Marc Bloch in Apologia della storia (p. 74-75), è il nume tutelare di un romanzo composto da pagine “plagiate” che però il lettore - se ne ha i mezzi - può identificare, inserti di altre opere raccontati a voce dagli autori stessi (lo stesso Mattogno li identifica nella nota 9), documenti di incerta paternità.
Basta naturalmente ricordare la centralità che nella narrazione assumono i Protocolli dei Savi Anziani di Sion. Mattogno rappresenta coloro che dei Protocolli, di cui parleremo a lungo, pensano: «Sarà un falso, ma è un libro che dice esattamente ciò che gli ebrei pensano, quindi è vero». La citazione è tratta da Umberto Eco, gli ebrei e i complotti, dialogo fra Eco e il rabbino Riccardi Di Segni coordinato da Wlodek Goldkorn, che esce sul numero di «L’Espresso» del 28 ottobre 2010 (e non 2012 come erronemente indicato da Mattogno alla nota 38). Sono le parole con cui Eco riassume la posizione dell'antisemita britannica Nesta Webster.
Mattogno non accetta che Eco si opponga all’antigiudaismo in veste di romanziere e non di storico. Alla fine lui stesso si sente in dovere di proporre un ipotetico testo dei Veri Protocolli dei Savi Maestri di Sion, creando, a sua volta ma con nessuna ironia, un falso testo nato dall’accostarsi di citazioni estratte dai documenti più disparati che facciano comodo allo scopo che si è prefisso. Di Il cimitero di Praga potremmo dire quello che all’interno del romanzo stesso l’abate Dalla Piccola scrive commentando i racconti fatti da Boullan: «Non eravamo sicuri che ci raccontasse la verità, ma non era questo il punto» (p. 446).
La domanda quindi non è se il romanzo di Eco è storicamente veritiero (naturalmente no). La domanda è: i lettori sono in grado di decodificarlo in maniera corretta? È questa la preoccupazione del rabbino Riccardo Di Segni nel dialogo pubblicato su «L’Espresso» citato prima.
Di Segni afferma:
«"Penso che il messaggio di Eco sia ambiguo [...] Il lettore cosa ne capisce? È vero o non è vero ciò che si racconta? [...] Alla fine il lettore si chiede: ma questi ebrei, vogliono o non vogliono scardinare la società e governare il mondo? Il problema è che non si tratta di un libro scientifico che analizza e spiega i fenomeni. Il Cimitero di Praga è un romanzo. E in più ha una trama avvincente, che finisce per convincere”».
Questa la risposta di Eco:
«“Il rabbino mi chiede: cosa era vero. Io rispondo: il lettore dovrebbe capire che niente era vero. Che era tutto dossieraggio, una costruzione d[e]i servizi. Sono cosciente delle ambiguità che possono nascere. Ma la mia intenzione era quella di dare un pugno nello stomaco del lettore. [...] Credo di aver dato al lettore tutte le chiavi per capire"».
La questione di fondo è dunque sempre la capacità del lettore di decodificare il testo del romanzo. O, che è un’altra faccia della stessa medaglia, la possibilità che il testo offra agganci a chi in mala fede vuole stravolgerne il senso.
Forse andando oltre le proprie intenzioni, Eco ha quindi creato un romanzo che pone esattamente gli stessi problemi interpretativi discussi al suo interno relativamente a molti altri documenti e all’uso che ne è stato fatto (o se ne sarebbe potuto fare).
Sul tema della falsificazione di documenti scritti si veda anche l’interessante capitolo Il falsario come autore che Luciano Canfora aggiunge all’edizione accresciuta di Il copista come autore pubblicata nel 2019 (la prima edizione era uscita nel 2002).
Gian Pio Mattogno, L'eco di Israele. Falsi propagandistici, verità occultate e ambigue imprudenze nel romanzo di Umberto Eco Il Cimitero di Praga, Genova, Effepi, 2013.
Umberto Eco, gli ebrei e i complotti, a cura di Wlodek Goldkorn, «L’Espresso», LVI, n. 43, 28 ottobre 2010.
