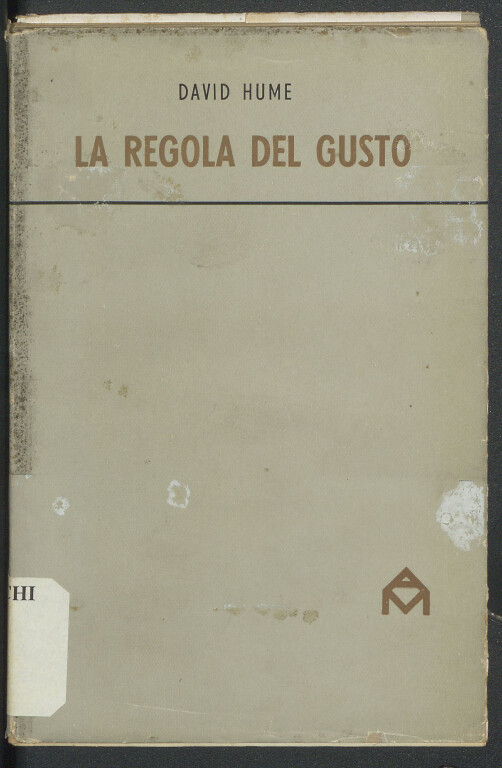
Album "Apocalittici e integrati"
In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del saggio Apocalittici e integrati di Umberto Eco (1964), che fanno riferimento ai temi trattati nell’opera o hanno fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione critica del lavoro di Eco.
Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie). Non solo non c’è pretesa di esaustività, poniamo anzi una dichiarazione preventiva del fatto che maggiore attenzione si è data alla parte relativa ai fumetti, considerata più interessante e adatta al percorso di lettura del nostro gruppo, mentre canzone e TV sono trattate qui in maniera episodica. Non si fanno inoltre quasi riferimenti ai capitoli Cultura di massa e “livelli” di cultura e La struttura del cattivo gusto, che naturalmente sono però la base teorica implicata nella presentazione dei documenti da noi preparata come del lavoro di analisi dei testi - grafici, testuali e sonori - fatta dall’autore.
Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 1964.
I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.
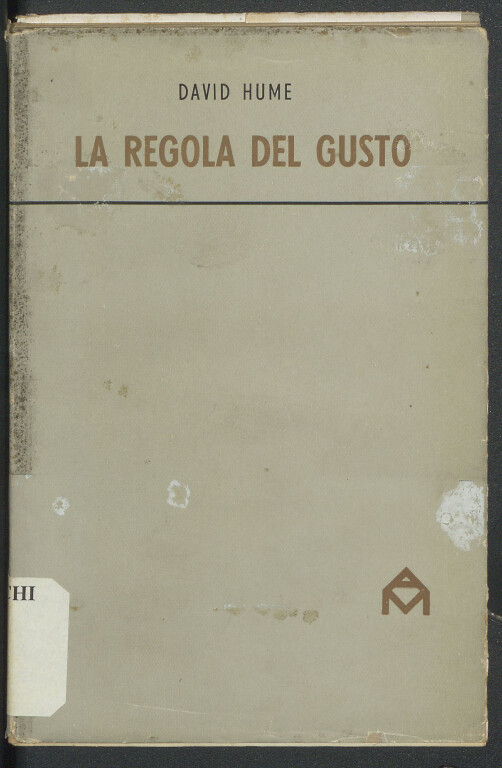
David Hume, La regola del gusto (1946)
Faremo solo brevi accenni agli strumenti teorici che stanno alla base delle analisi di Eco, privilegiando invece i testi analizzati sulla scorta delle indicazioni tratte dalla teoria estetica e della produzione e ricezione degli oggetti culturali. Facciamo un’eccezione per citare il saggio di David Hume Of the Standard of Taste, su cui si basa il paragrafo Hume e l’indiano: introduzione alla ricerca empirica (p. 169-175), nel quale Eco stabilisce alcuni assunti che varranno per l’analisi dei diversi mass media che si accinge a studiare.
Qualunque prodotto culturale ha una struttura oggettiva che va compresa e analizzata. Questa stessa struttura però permette (anzi, deve permettere) una «variabilità delle fruizioni» (p. 170) dell’opera stessa. Quindi la ricezione dell’opera varia da un ricevente all’altro. L’indiano di Hume è il rappresentante di una cultura altra, dissimile dalla nostra, che proprio in virtù di questa diversità fruisce e interpreta un’opera d’arte prodotta all’interno della nostra cultura in maniera differente da come la interpretiamo noi.
Questo aspetto acquista maggiore rilievo quando il testo analizzato rientra all’interno del sistema della comunicazione di massa.
«Lo studioso di estetica che esercita la propria riflessione sui fenomeni della fruizione artistica, quali ce li ha proposti la tradizione occidentale sino a mezzo secolo fa, si trova in una situazione di ricerca in cui, sostanzialmente, l’autore dell’indagine e il soggetto di essa coincidono. [...]
Che io [il ricercatore, n.d.r.] riconosca l’esistenza di un pubblico assai dissimile da me e dai miei simili conta scarsamente: poiché io so che l’opera è stata prodotta per un pubblico di miei simili [...] e che i miei dissimili, anche se in un modo o nell’altro consumeranno l’opera, ne coglieranno evidentemente gli aspetti accessori, la contempleranno in forma ridotta, la fruiranno solo a certi livelli. [...]
Ma nell’orizzonte di una cultura di massa, ciò che viene messo in questione è proprio la validità di una fruizione esemplare [...] Si ha così che per un oggetto, analizzabile strutturalmente, si danno una varietà di reazioni possibili, il cui controllo sfugge all’indagatore [...]
Nel campo delle comunicazioni di massa il ricercatore non può più coincidere con la cavia. Da un lato sta l’opera, dall’altro (per rifarci a Hume) una moltitudine di Indiani.
Le reazioni di questi indiani non sono più ricostruibili dal ricercatore [...]. Gli “altri” sono molto di più e più differenziati, di quanto le sue possibilità di congenialità gli consentano di divenire. [...] Solo la ricerca empirica, sul campo, può illuminare il ricercatore sulle varie possibilità di reazione all’oggetto. [...]
Ciò non rende affatto priva di validità una ricerca sulle strutture: la istituisce anzi come il primo indispensabile passo della ricerca. E ciò non impedisce che, nel corso di una ricerca sulle strutture, il ricercatore avanzi delle ipotesi sul tipo di fruizione che una data struttura potrà consentire a un tipo qualsiasi di fruitore. La nostra “lettura di Steve Canyon” si è mossa tutta in tal senso. Salvo che non costituisce il punto di arrivo di una ricerca sui mezzi di massa, ma al massimo un punto di partenza» (p. 171-175).
In questa lunga citazione si tocca una questione di metodo fondamentale non solo del libro, ma di un nuovo modo di affrontare lo studio dei mezzi di comunicazione di massa, che li qualifichi come oggetti di studio importanti e problematici, da indagare con adeguate basi teoriche. Che si tratti di fumetti, canzonette o programmi TV.
David Hume, La regola del gusto, a cura di Giulio Preti, Milano, Minuziano, 1946.
